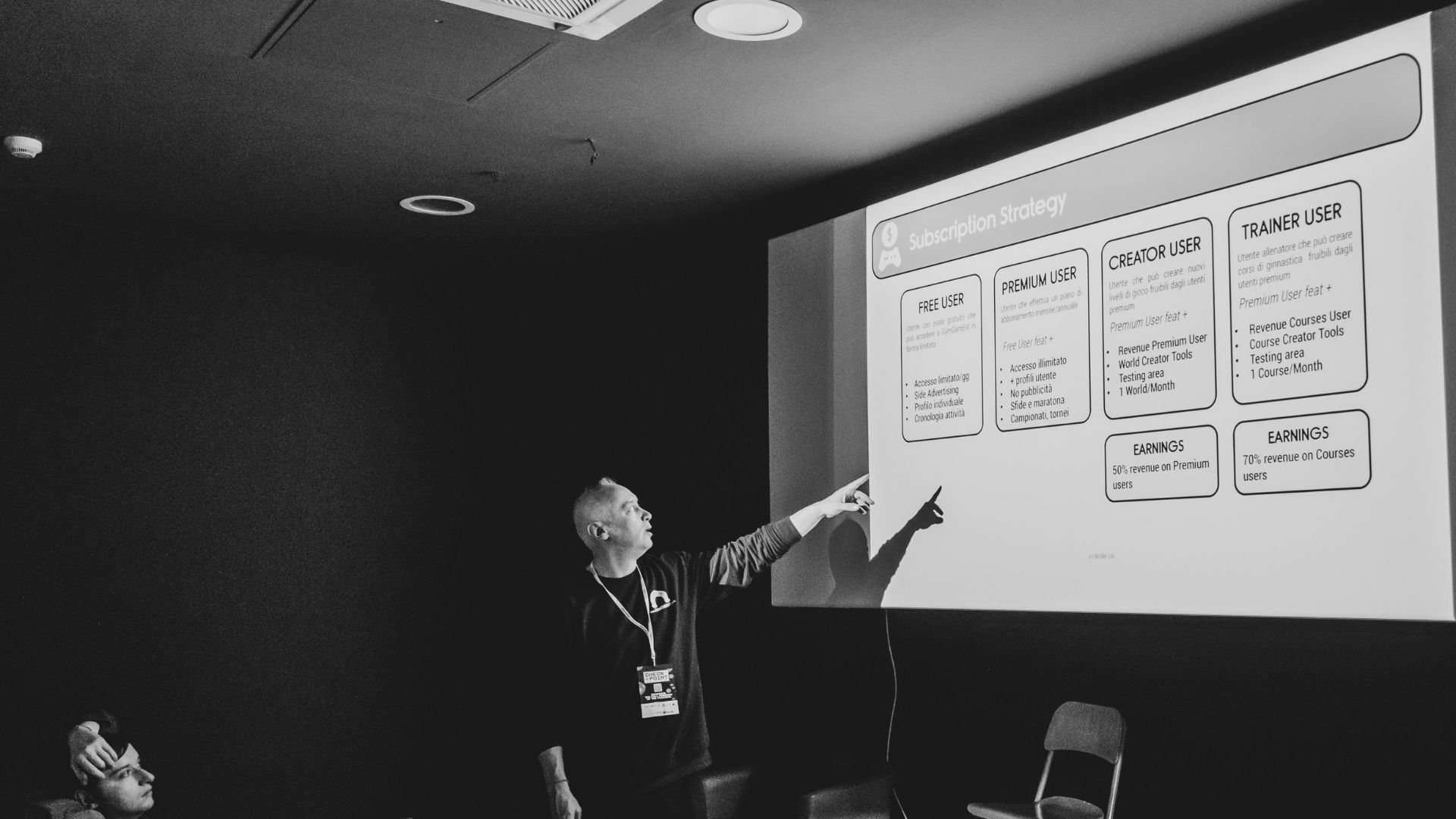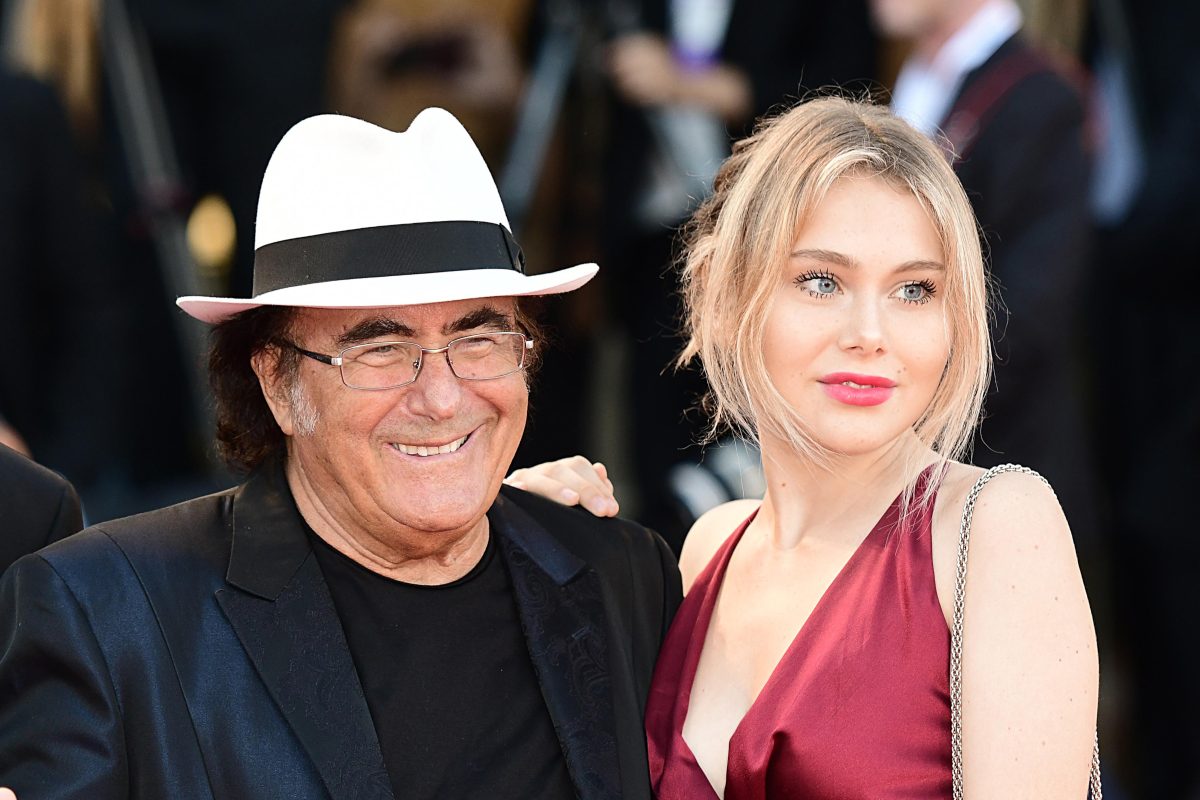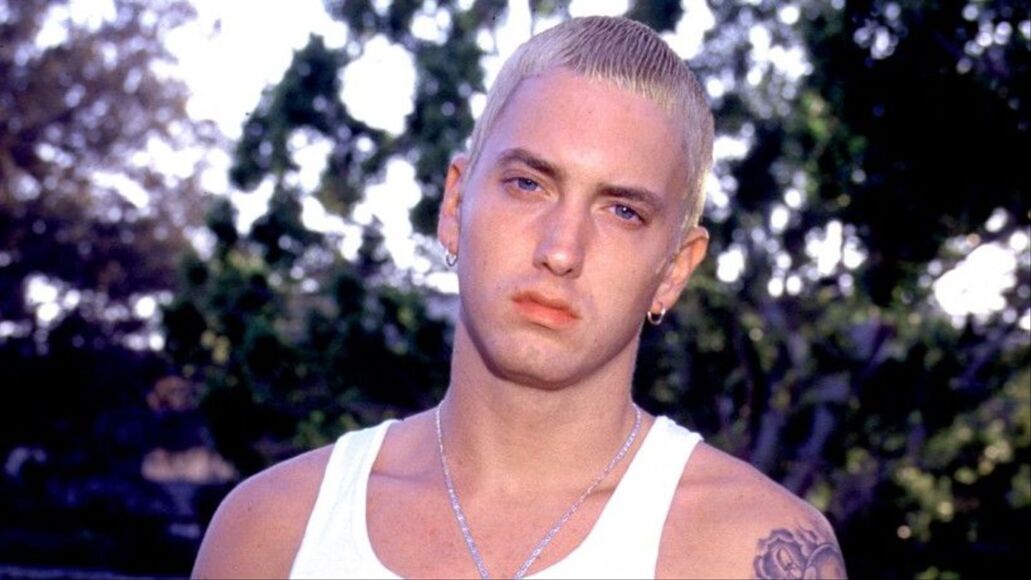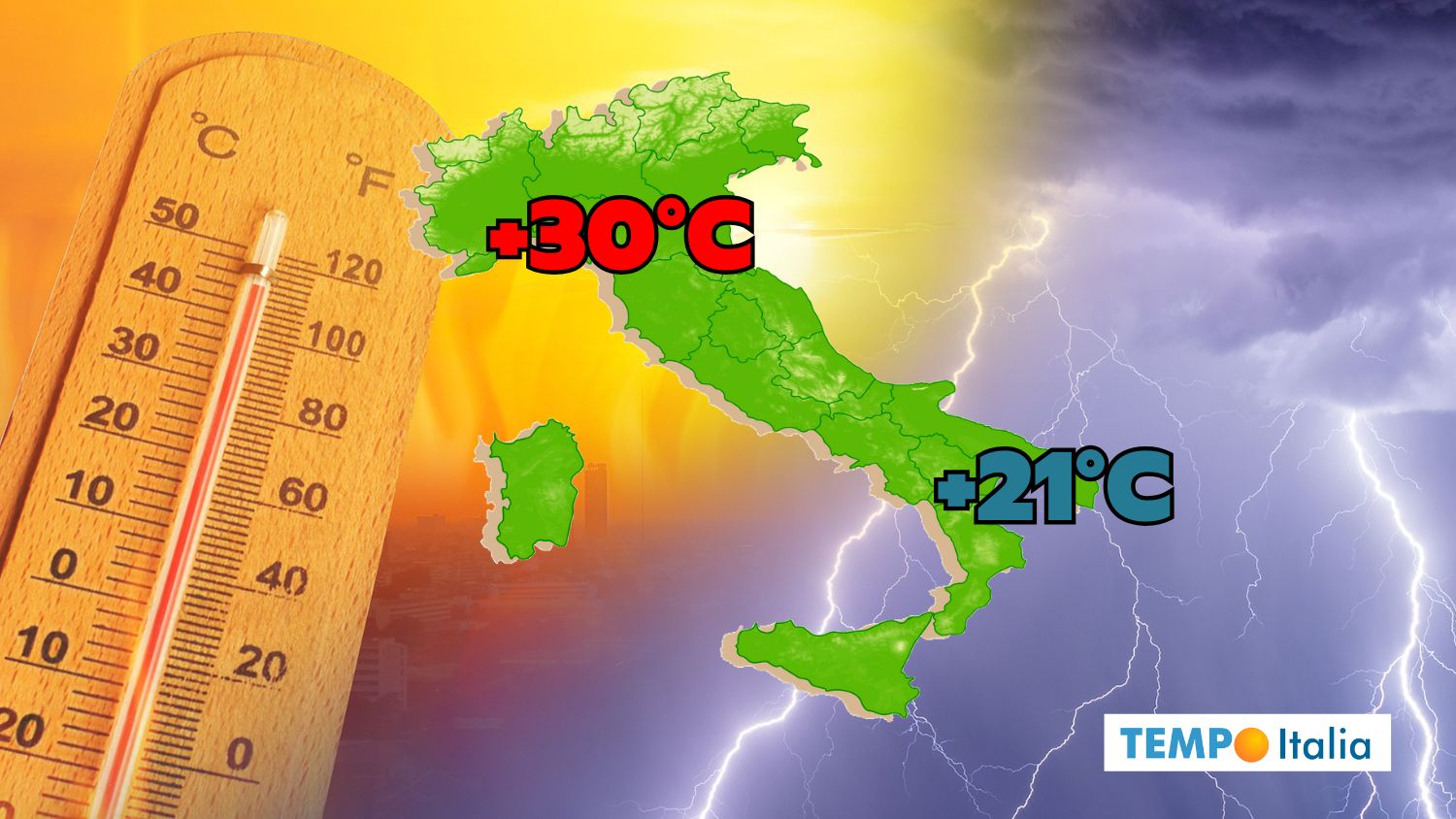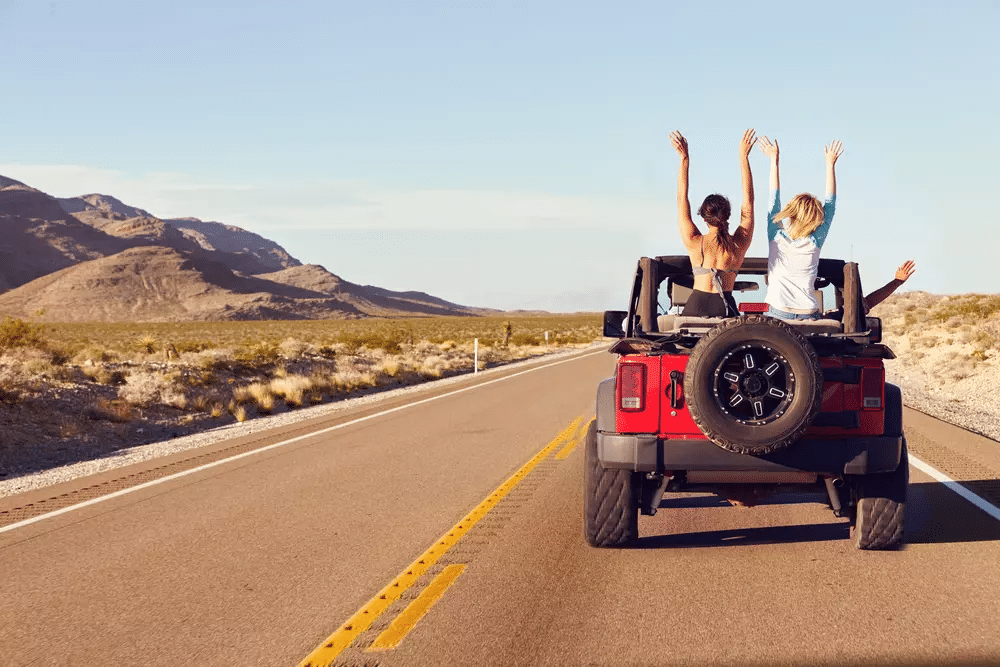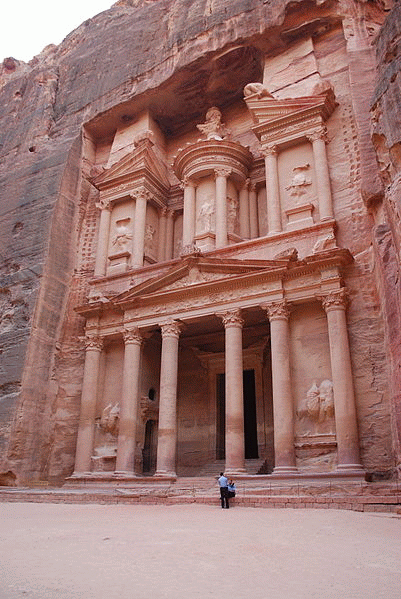Terry Blue, se la musica non è un “prodotto”
In epoca di produzione continua e standardizzata di musica, e dove la velocità e la quantità hanno preso definitivamente il sopravvento sulla qualità e sulla profondità (come da voleri di Daniel Ek…), non può che colpirti un progetto artistico dove la presentazione di sé all’interno del comunicato stampa è un piccolo pezzo di alta letteratura,… The post Terry Blue, se la musica non è un “prodotto” appeared first on Soundwall.

In epoca di produzione continua e standardizzata di musica, e dove la velocità e la quantità hanno preso definitivamente il sopravvento sulla qualità e sulla profondità (come da voleri di Daniel Ek…), non può che colpirti un progetto artistico dove la presentazione di sé all’interno del comunicato stampa è un piccolo pezzo di alta letteratura, di forte sincerità ed atipica intimità. Qualcosa di lungo e anche scomodo da leggere, se uno è colto da fretta e voglia di capire in due righe cosa sia o non sia un disco, un artista, insomma, un “prodotto”. Tanta roba. Tanta, inaspettata roba.
Ma Leo Pusterla, il primo fautore ed originatore del progetto Terry Blue, fa di tutto per non essere e per non sentirsi un “prodotto”. A costo di complicarsi la vita da solo. Lo senti nella sua musica; lo sentivi dell’intimo ed intensissimo “Chronicles Of A Decline” di cinque anni fa, lo senti nel più eleborato “Lakewoods” uscito adesso, ora che Eleonora Gioveni è diventata ufficialmente co-titolare del progetto e che si guarda verso un mondo musicale non più Damien Rice (per darvi una reference) quanto molto più Archive (idem).
È musica di alta qualità. Pop maturo, complesso, sofisticato. Ma comunque molto emotivo, emozionale: accarezza, prende al cuore. È stato di altissima qualità anche lo scambio con Leo per costruire questa intervista: se pensiamo a quanta fatica spesso devi fare per cavare parole e concetti a gente magari bravissima coi social (loro, o il loro social media manager…) e di grande successo, ti viene un po’ di sconforto. Oggi sembra quasi che i ragionamenti complessi ed estesi siano una zavorra, non interessino a (quasi) più nessuno o, almeno, non facilitino la vita se vuoi farti largo, se vuoi farti notare. Sarà per sempre così? Di sicuro, a pubblicare interviste così e a mettere in luce progetti quasi-di-casa-nostra (Leo infatti è ticinese) che rischiano di passare inosservati rispetto ai meriti, sappiamo che anche se andrà tutto male non avremo nulla da rimproverarci.
Com’è, oggi, la scena musicale italiana vista dal “vicinato” del Ticino e da artisti di lingua italiana che però scelgono per esprimersi l’inglese e riferimenti musicali di stampo profondamente anglosassone?
La scena musicale italiana è vista, almeno a parer mio e secondo l’esperienza dei diversi artisti che conosco ed incontro sul territorio ticinese grazie alla mia pratica di produttore – oltre che di musicista nel progetto Terry Blue – in maniera “bipolare”. Se da un lato il fascino esercitato dalla scena indie italiana, che da sempre e ancora oggi ci sembra essere particolarmente rigogliosa, continui ad influenzare la produzione artistica svizzero-italiana, credo che sia dall’altro sempre più difficile, almeno per coloro che vogliono percorrere una strada musicale “libera”, “indipendente” e sperimentale, riconoscersi nel mondo del mainstream, dei talent show e dell’industria musicale “consumistica” e algoritmica che ha caratterizzato le produzioni più importanti degli ultimi anni in Italia. Rischio naturalmente di mescolare eccessivamente ciò che é il mio parere personale e ciò che riscontro nelle discussioni, molto frequenti, che intraprendo con i musicisti del territorio ticinese, ma credo che questa visione sia piuttosto condivisa così come l’impressione che il mondo della musica dal vivo in Italia sia di difficile accesso e, come d’altronde ovunque, particolarmente soggetto alla presenza di agenzie di booking e promoters e di una generale visione della musica dal vivo forse troppo dettata dai numeri (followers, ascolti, ecc.) e poco incentrata sull’effettiva qualità e ricerca dei progetti proposti. Per quanto riguarda invece l’utilizzo della lingua inglese da parte di artisti ticinesi, e di conseguenza di madrelingua italiana, credo che anche in questo caso ci siano due discorsi distinti da affrontare: é cosa certa che, per alcuni, la lingua inglese possa fungere da mezzo per raggiungere un bacino di pubblico più ampio, europeo, ma é altrettanto vero che per altri (ed io mi inserisco in questa seconda categoria) sia piuttosto una scelta dettata dal genere, dalle influenze e dagli ascolti personali di coloro che si cimentano nella produzione musicale. Io, per esempio, ho provato più volte a scrivere in Italiano ma “arrivo” da un mondo di ascolti profondamente anglosassone ed americano e molto meno dalla scena musicale italiana.
(Eccolo, “Lakewoods”; continua sotto)
Rovesciando la domanda: in Italia si parla troppo poco della scena musicale svizzera, che invece a me è sempre sembrata molto interessante e qualitativa. Quali sono le città più interessanti, quali le scene più vive? Quale possibile itinerario suggerire (di live club, di web magazine da leggere, di posti da frequentare…) se uno avesse la possibilità di farsi qualche settimana di full immersion nella Confederazione Elvetica?
La scena musicale Svizzera è sorprendentemente vasta, variegata e, a parer mio, interessante. Mi é difficile stilare una vera e propria lista, sicuramente consiglierei vivamente di visitare Zurigo, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra per poter approfittare di concerti dal vivo di qualità e per respirare un’aria “artistica”, ma anche qui mi sorge spontanea una premessa. Specialmente nel cantone da cui provengo e in cui abito, il Ticino, la scena culturale e musicale sta vivendo un vero e proprio “momento d’oro” a parer mio. Questo, tuttavia, si scontra con una triste realtà contro la quale ci troviamo a combattere ogni giorno, di natura politica e sociale: l’assenza totale di spazi di espressione indipendenti e di riconoscimento professionale (specialmente, ambito che conosco meglio, per quanto riguarda i musicisti) a scapito di una visione estremamente commerciale, economica e, ahimé, turistica della cultura. Sono innumerevoli gli esempi di progetti musicali svizzeri che partecipano a tour europei in grande scala (io, nel mio piccolo, rispondo a queste domande nel mezzo della mia tournee di presentazione in Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Italia e Repubblica Ceca), ma tutti noi fatichiamo ad essere riconosciuti come professionali e professionisti. Non posso negare la presenza di innumerevoli ed importanti sostegni, o finanziamenti, per progetti che si presentano in un determinato modo, ma forse questo non basta e ciò che più manca sono le realtà non istituzionali, gli spazi per la cultura che viene dal basso e non dall’alto. Gli investimenti più importanti sono sempre in altri ambiti, lo sport in primis, ed é estremamente difficile dare spazio alla vastità di bellezza che credo esista nel territorio svizzero in assenza, proprio, di spazi in cui presentare la cultura e la musica. Cito comunque una meravigliosa trasmissione radiofonica, purtroppo ormai tagliata dei fondi necessari ad esistere, chiamata “Confederation Music Sessions”, uno spazio di scoperta per musica non convenzionale di origine svizzera a cura di Marco Kohler.
Forse, un po’ idealisticamente, credo che la musica e l’industria musicale debba subire un drastico, durissimo cambiamento affinché il focus torni sull’opera e non sul “mostrarsi in quanto musicista”
“Lakewoods” è un notevole strappo, in primis a livello di arrangiamenti ma non solo, rispetto a “Chronicles Of A Decline”: quanto è stato difficile, quanto è stato lacerante e quanto è stato invece lacerante questo strappo?
È una domanda molto interessante, a cui cerco di rispondere partendo da due punti di vista diversi. Da un lato, “Chronicles of a Decline” era un disco estremamente necessario, personale ed intimo, nel quale io ed Eleonora ci siamo confrontati con noi stessi, con “ciò che abbiamo in mano” da un punto di vista strettamente musicale. Ci affascinava infatti l’idea di restituire quella che era la nostra formazione “live”, presentata nei vari anni di concerti, estremamente acustica, nuda e viscerale. In un certo senso, credo che anche le tematiche di “Chronicles of a Decline” avessero bisogno di questo tipo di sonorità e mondo musicale, un mondo scarno ed acustico. Nel caso di “Lakewoods” mi rendo conto che il punto di vista della voce narrante, la mia, vuole essere più universale, politico e sociale, e cerca forse di avvicinarsi ad un’analisi del mondo meno egocentrica, in un certo senso, e meno autobiografica. Di conseguenza, lo stridore e la complessità compositiva di questo nostro nuovo lavoro cerca di rispecchiare proprio lo stridore e la complessità del mondo che ci circonda e che osserviamo con preoccupazione ogni giorno. Come ho già scritto in altre interviste non riesco, non più, a trovare una sonorità “piacevole” o “dolce” in un mondo che di piacevole e dolce sembra avere ben poco.
(L’intimita di “Chronicles Of A Decline”; continua sotto)
Quanto la musica di Terry Blue può vivere bene all’interno di un consumo di musica che si basa molto sugli algoritmi?
Pochissimo, ne sono convinto. E, in realtà, un po’ ne vado fiero e credo che gli aspetti politici e sociali a cui accennavo in precedenza trovino una traduzione anche nella “non consumabilità” della nostra musica. Forse, un po’ idealisticamente, credo che la musica e l’industria musicale debba subire un drastico, durissimo cambiamento affinché il focus torni sull’opera e non sul “mostrarsi in quanto musicista”. Per me si tratta, prima di tutto, di una necessità e – benché sia ingenuo pensare che, nel momento di scrivere un brano, una parte di noi non si aspetti un qualche tipo di riconoscimento dal pubblico – resta un gesto mio, un mio bisogno e non riesco a concepire il creare subordinato alla richiesta, al ciò che piace o che pensiamo che possa piacere. L’arte é prima di tutto, per me, ricerca, esplorazione, contrasto e ancora una volta stridore, non mi riconosco, non ascolto e non apprezzo ciò che viene creato con il puro scopo di compiacere (e compiacersi).
Per Terry Blue nasce prima la struttura melodica ed armonica della canzone, o prima l’idea concettuale e le parole e da lì poi si dipana il resto?
Ho sempre faticato molto ad identificare un “modus operandi” nel nostro comporre canzoni. Credo che la prima forza motrice, la primissima, resti il mondo che mi circonda, le persone che incontro, la loro esperienza e l’intersecarsi di quest’ultima con la mia. Anche in questo caso mi trovo molto riluttante e restio nei confronti della musica “fatta per fare musica”, non perché io creda che non debba esistere ma semplicemente perché non la so fare. Non riesco a non cercare un motore sociale, un profondo bisogno di analisi del mondo e del malessere del nostro tempo, ed in “Lakewoods” più che mai questo é avvenuto un maniera molto randomica, come una sorta di strana alchimia. Spesso sono i testi a nascere per primi, a volte sono invece dei groove di batteria, dei suoni che troviamo un po’ per caso, dei sintetizzatori distorti oltre il necessario che di colpo diventano fondamento stesso del brano, dei field-recordings o semplicemente delle idee, spesso improvvisate, sui cui poi si costruisce il resto.
(Terry Blue, fotografati da Alan Koprivec; continua sotto)

Cinque dischi da isola deserta, se possibile dando anche una breve spiegazione (…o un aneddoto, se è il caso!) per ogni singola scelta.
Scelgo come primo disco “I Forget Where We Were” di Ben Howard, e qui la spiegazione é molto semplice: sceglierei unicamente dischi suoi da portarmi su un’isola deserta perché credo che sia l’artista che più mi ha influenzato nel mio percorso. E non riesco a dire quale sia il mio preferito, quindi scelgo questo perché l’ho visto suonato più volte dal vivo e, davvero, l’ho ascoltato in maniera smodata.
Al secondo posto metto “Bon Iver” di Bon Iver, un altro disco per me fondamentale. Se da un lato le tematiche toccate da Justin Vernon nella sua lirica mi toccano meno di quelle di Ben Howard, la ricerca di e la sperimentazione sonora del primo mi ha sempre profondamente affascinato ed influenzato.
Al terzo posto faccio un salto temporale e scelgo “Songs of Love and Hate” di Leonard Cohen. Dirò la verità: non credo sia il suo miglior disco ma credo che nella sua profonda cupezza e oscurità racchiuda uno dei momenti più veri e sinceri del cantautore. Inoltre, lo associo sempre ai viaggi in auto in famiglia con i miei genitori, a quante volte abbiamo ascoltato “Avalanche” e a come guardare i paesaggi alpini con quel disco come sottofondo mi facesse “viaggiare”.
Al quarto posto metto “If You Leave” di Daughter, il progetto della cantautrice Elena Tonra. Ho sempre trovato unico il suo approccio canoro e le sonorità sempre riconoscibili dei suoi musicisti. I suoi testi, di un intimità quasi spiazzante, mi hanno ispirato molto.
Al quinto posto (ma non si tratta di una classifica, anzi!) metto un disco che ha poco a che fare con i precedenti. Non si tratta neppure di un disco ma di una compilation, ossia “Finest Hour” di Duke Ellington. Durante la mia adolescenza ho avuto la fortuna di poter condividere uno spazio, un appartamento che chiamavamo “La Topaia”, nel quale ci ritrovavamo insieme al nostro vasto gruppo di amici a suonare, passare le serate e fare tutto ciò che farebbe un pugno di sedicenni con uno spazio tutto loro. Ecco, nella Topaia passavamo in loop questo disco, fumoso come l’ambiente.
Il legame con la musica è più una benedizione o, invece, una ossessione a cui arrendersi?
Questa domanda mi sorprende molto perché racchiude una risposta verbalizzata in modo così preciso e così fine… “Un’ossessione a cui arrendersi“: non credo di essere mai stato in grado di definire meglio il mio rapporto con la musica. Non credo che ci sia alcuna benedizione (anche perché é una parola che disconosco nel modo più totale) nella pratica artistica tutta. Al contrario, credo che il gesto creativo sia un percorso estremamente difficile, pericoloso e soggetto a cadute, ripensamenti e crisi. Diffido molto di chi trova una “terapia” nella musica perché non credo, non più, che possa essere soltanto uno sfogo, un vomitare il proprio malessere al fine di automedicarsi. Al contrario, credo sia fondamentale che il punto di partenza sia, certo, la tragedia umana, la nostra quotidiana sconfitta, ma che sia necessaria un’elaborazione dell’oscurità e del mondo: qui sta per me la differenza. In conclusione “ossessione” credo possa definire molto bene il mio rapporto con la musica, a cui mi arrendo ma a cui allo stesso tempo cercherò sempre di resistere, specialmente nei tempi bui che attraversiamo, specialmente oggi che “resistere” é diventato, a parer mio, un obbligo morale e civile. Nella vita e nella musica.
The post Terry Blue, se la musica non è un “prodotto” appeared first on Soundwall.