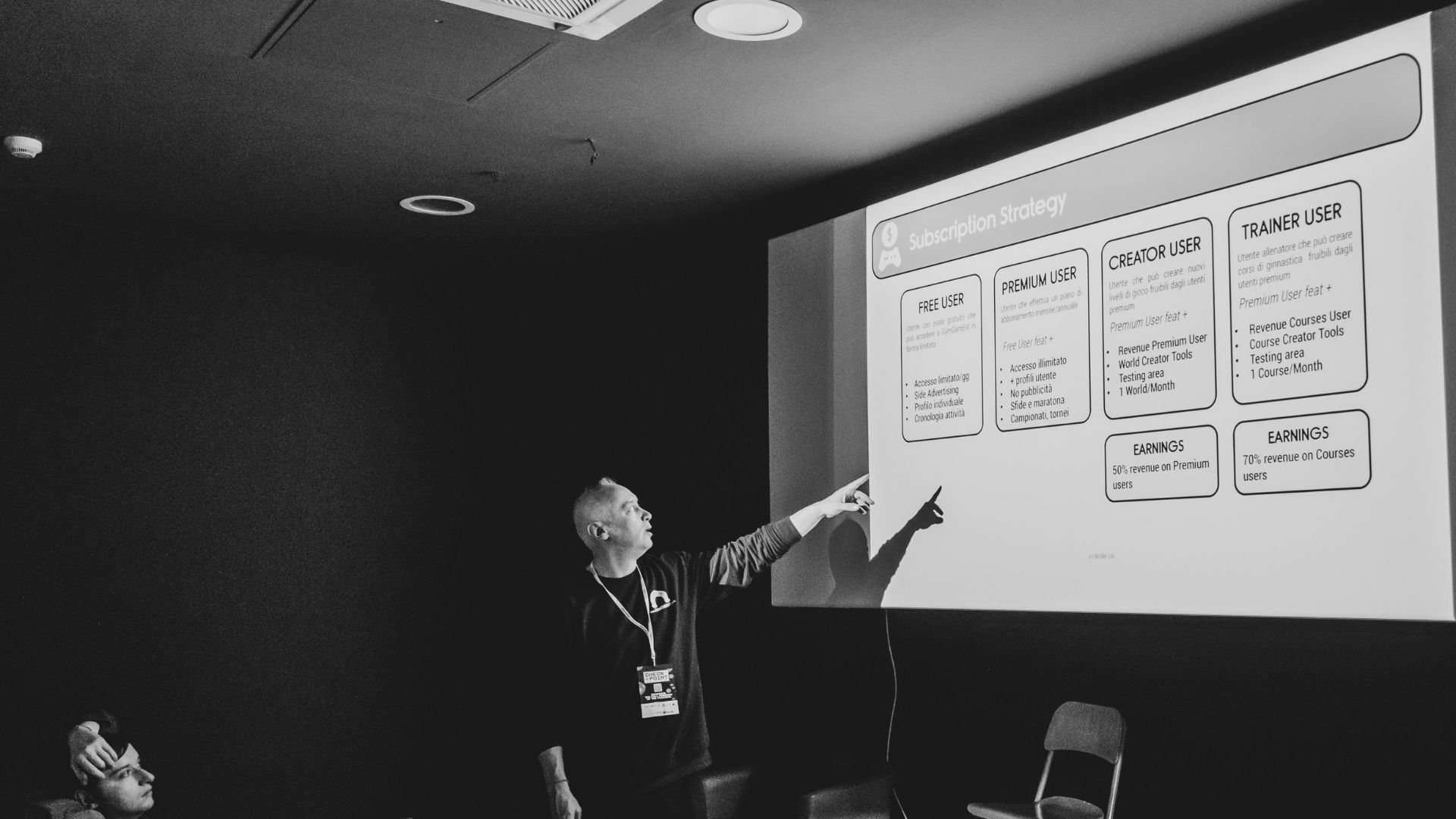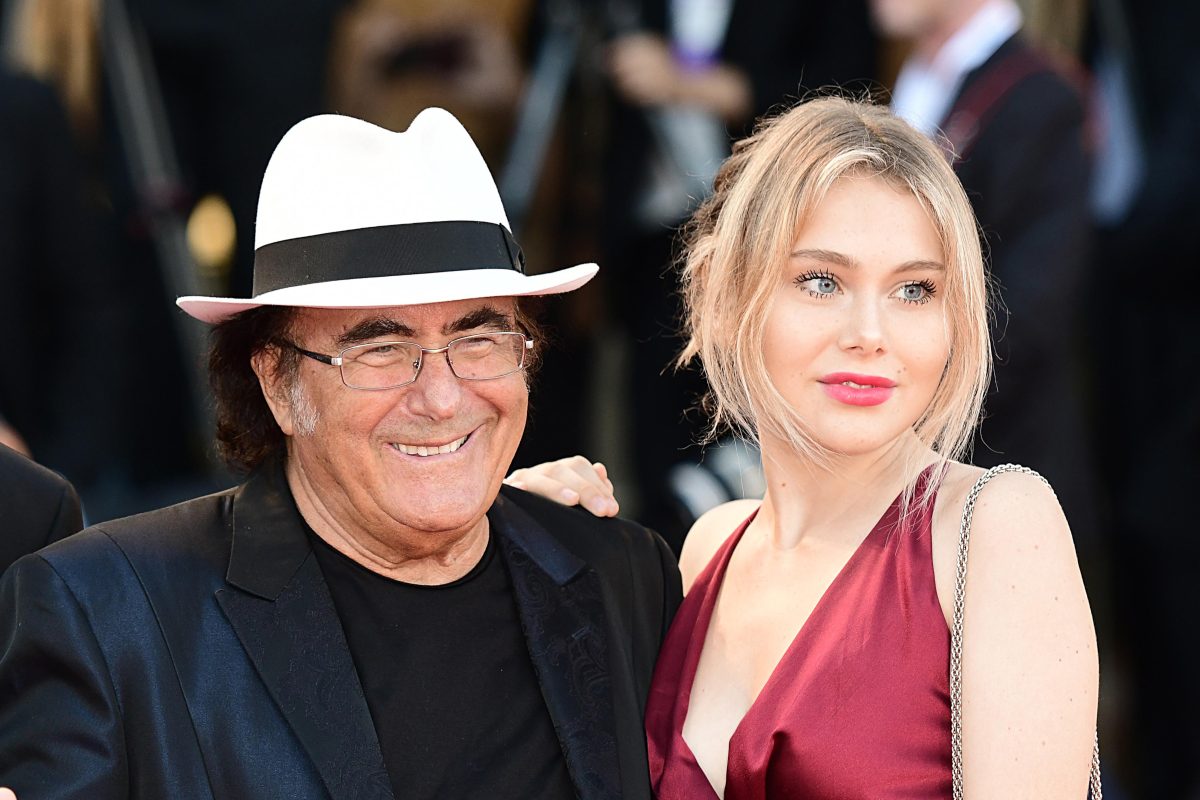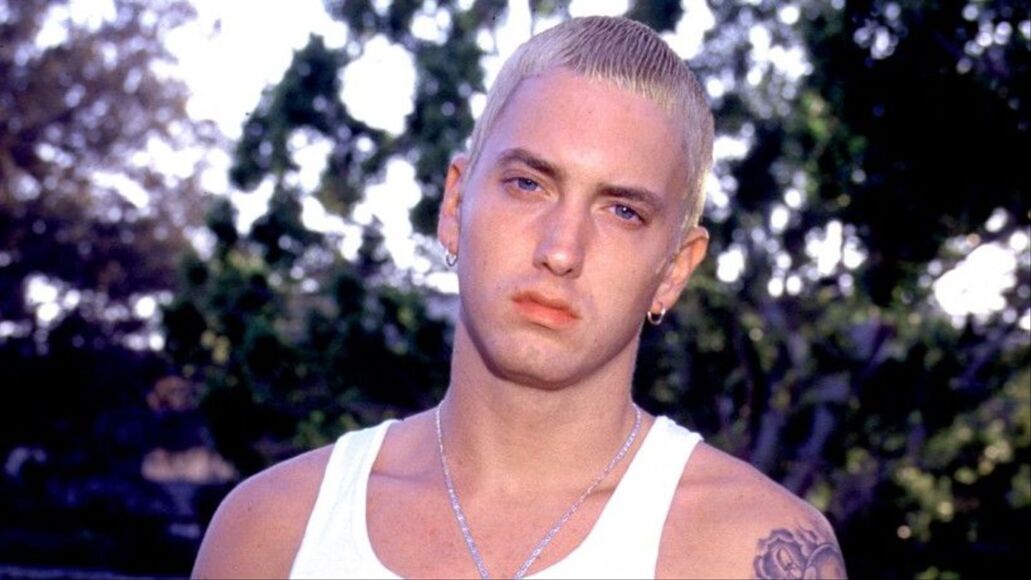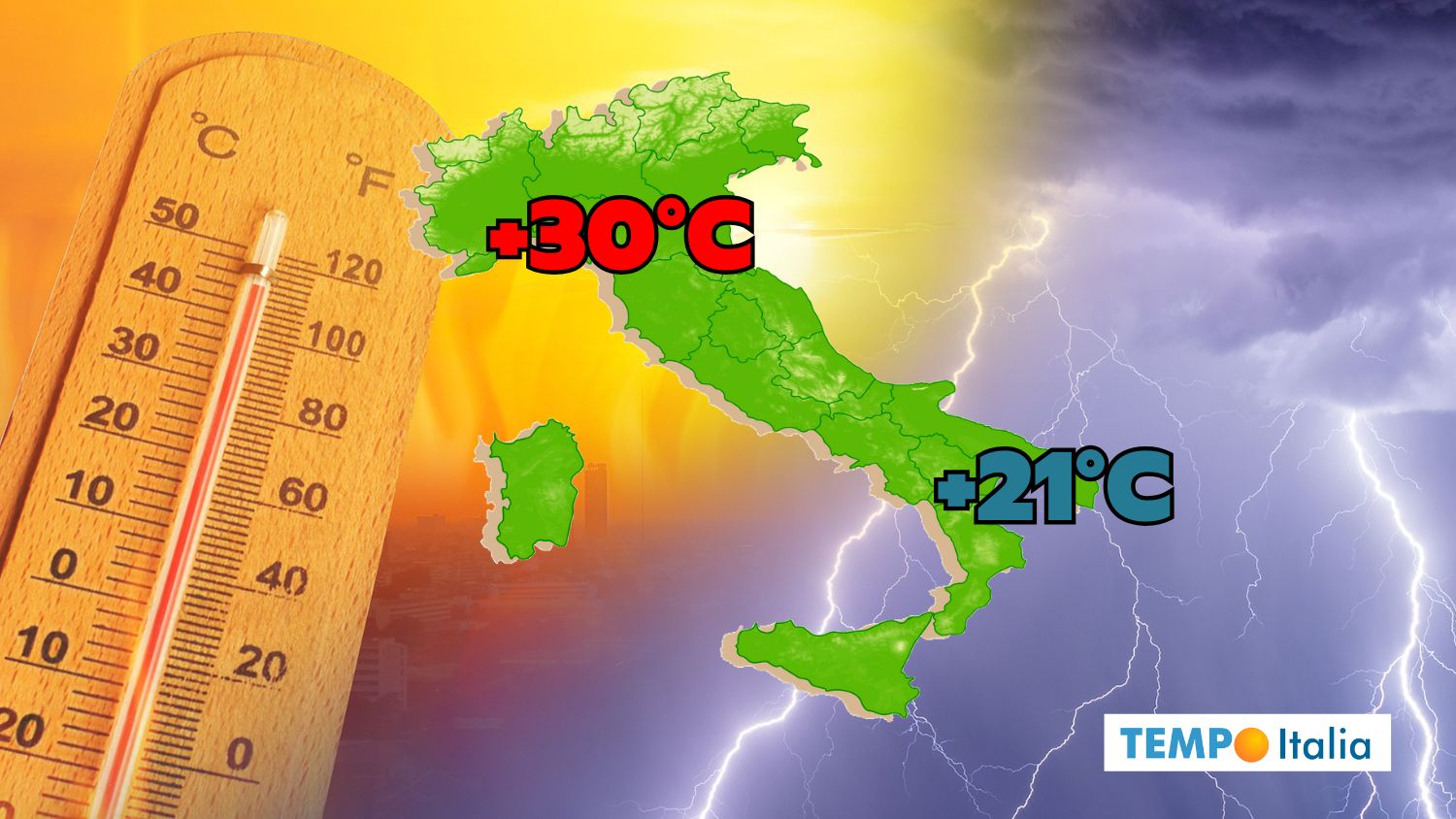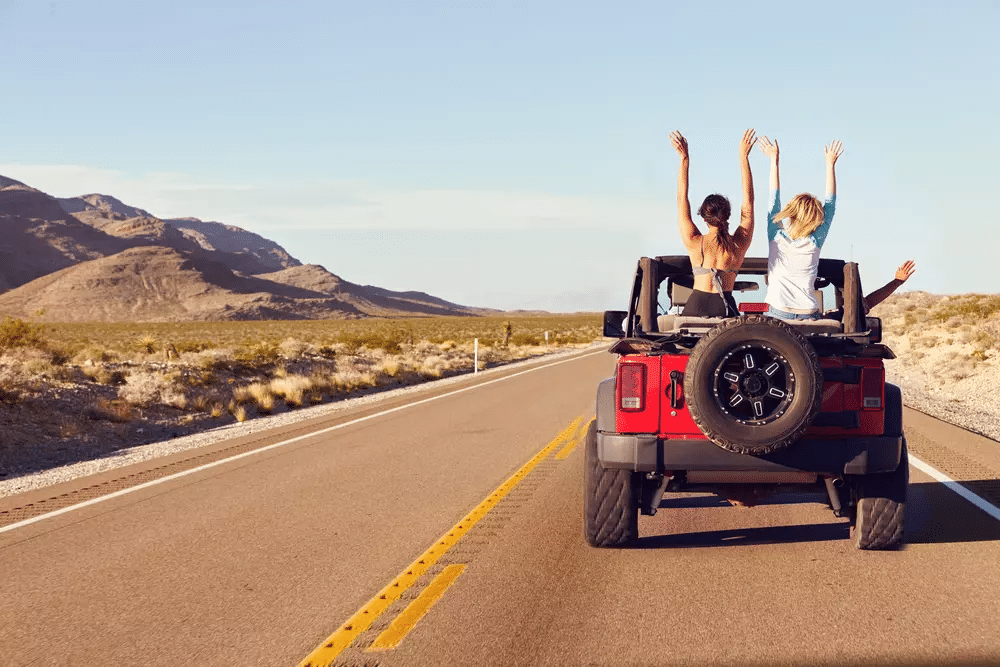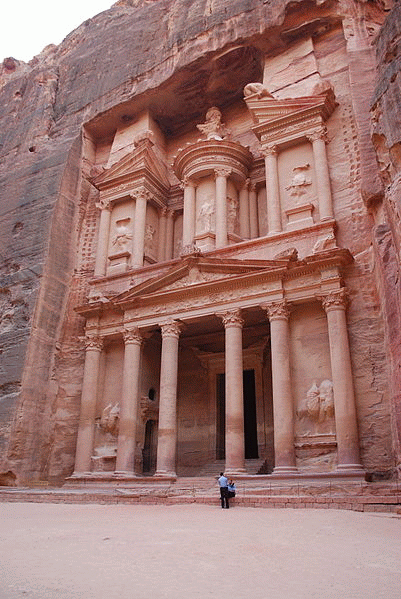Jazz Is Dead 2025: l’infinito e oltre, intervista ad Alessandro Gambo
L’ottava edizione di Jazz Is Dead! è la più grande e ambiziosa di sempre. Non tanto nei classici termini a cui s’associa il circuito festivalero, che valuta il proprio rilievo sulla base della fama dei suoi headliner, quanto per la qualità e varietà degli artisti chiamati a popolare il cartellone, ognuno eccellente nel proprio ambito, fuori dagli hype d’accatto. Una curatela pensata in libertà all’interno di un ambito in cui più ci si espande ed evolve, più si finisce in un sistema di cose che le limita. Ed è per questo e per altri motivi che il festival dichiara questa edizione come l’ultima di un percorso. Un punto di svolta e al contempo un momento per riflettere su quanto si è raccolto, cogliere i frutti di un cammino che alla base pone la cultura all’ascolto di musiche lontane dai grandi riflettori. Ne abbiamo parlato con Alessandro Gambo, ideatore e curatore del festival, che ci ha raccontato come nasce un programma così articolato, tra inseguimenti discografici, passioni coltivate da anni, scelte audaci e una visione che mette al centro l’accessibilità e la coerenza artistica più che i numeri. Un dialogo che attraversa decenni di ascolti, aneddoti da backstage e un’idea di comunità fondata sull’amore per la musica. L’edizione numero otto di Jazz is Dead ha un titolo evocativo, proprio come quelli delle edizioni che l’hanno preceduta. Perché “Infinito”? Lavorare e creare progetti per questa edizione è stata una cosa infinita. Poi si gioca facile col fatto che, essendo la numero 8, ribaltando di 90 gradi il numero diventa il simbolo dell’infinito. All’inizio pensavo di fare un’edizione senza pause musicali: avere la musica anche al mattino, magari con sleep-in concert, e non fermarci mai. Poi, in realtà, la produzione mi ha guardato malissimo, quindi ho dovuto limitare le mie fantasie. Però è un’edizione infinita perché, intanto, come numero di date siamo cresciuti — di quattro in più rispetto all’anno scorso, se non cinque. Ad esempio, con il Torino Jazz Festival ne abbiamo fatta una in più rispetto all’anno scorso con John Zorn; quest’anno abbiamo raddoppiato col Planetario e, in totale, ne facciamo tre anziché una sola. Abbiamo aggiunto un giorno in più anche durante i quattro giorni del festival. E abbiamo firmato una collaborazione — la prima — con Jazz Re:Found: il lunedì, che è la giornata dedicata ai bassi potenti, quindi Mad Professor, The Bug, Ghost Dubs e Cortex of Light, è co-firmata con loro. Quindi, appunto, siamo andati a consolidarci ancora di più nel tessuto — chiamiamolo — Nord-Ovest, e comunque in quello di alcuni festival vicini a noi. E quindi l’edizione è infinita perché, come numero di artisti, siamo sopra il centinaio; come numero di show, siamo ingranditi di molto. Come scrivevo nel comunicato stampa, nell’infinito ci fermeremo. E sarà questa l’ultima edizione per come conosciamo il festival. Potrebbe continuare a espandersi, potrebbe entrare in un buco nero… questo non lo sappiamo, lo capiremo alla fine dell’edizione. Così non volevo più andare avanti, nel senso che dopo un po’ ci si stufa e c’è bisogno di rinnovamento, e soprattutto stiamo entrando in delle logiche di mercato, di scelte artistiche che potevano andare a compromettere la libertà che abbiamo sempre avuto fino a oggi. E quindi mi sono dato questa edizione come punto di svolta. Vuoi fermare la corsa nel momento di massima accelerazione Eh sì, bisogna ogni tanto, secondo me, saper capire quando fermarsi. Fermarsi non vuol dire “ciao, è finita”, significa respirare. Io in questo periodo ho iniziato a fare meditazione, e mi piace come percorso, al contrario dell’idea di continua espansione. Secondo me è rischiosa: si entra in logiche che andrebbero a compromettere l’anima più intima di Jazz is Dead, che è quella della libertà, e di quello che noi abbiamo sempre fatto di pancia più che di testa. A mio avviso, la conquista più importante di Jazz is Dead è il radicamento nel territorio. Ha creato una continuità — anche grazie agli eventi satellite — e una cultura all’ascolto, magari seducendo una nuova generazione all’ascolto di suoni, suggestioni e modalità di approcciare la musica che, a livello generazionale, non sono più “esposti” come, ad esempio, negli anni ’90 Sì, esatto. Ti rendi conto che io, da promotore, da DJ, sono 25 anni che faccio — concedimi il termine — underground. Sia come DJ, come organizzatore, come selezione musicale e poi dopo con i locali che ho seguito, per cui ho curato la direzione artistica. Il più underground di tutti era il Dr. Sax e poi il Magazzino sul Po. Lì abbiamo sempre cercato di fare una cultura d’ascolto, di accessibilità, del fatto che appunto bisogna cercare di portare il pubblico, e quindi il pubblico deve rimanere. E a volte, appunto, rendere qualcosa accessibile aiuta, e noi siamo molto contenti di questo, perché si è creata attorno una comunità. Tanta gente viene a Jazz is Dead anche senza sapere quello che ci sarà. Si fidano tanto delle nostre scelte. Quindi sì, è molto bell

L’ottava edizione di Jazz Is Dead! è la più grande e ambiziosa di sempre. Non tanto nei classici termini a cui s’associa il circuito festivalero, che valuta il proprio rilievo sulla base della fama dei suoi headliner, quanto per la qualità e varietà degli artisti chiamati a popolare il cartellone, ognuno eccellente nel proprio ambito, fuori dagli hype d’accatto. Una curatela pensata in libertà all’interno di un ambito in cui più ci si espande ed evolve, più si finisce in un sistema di cose che le limita. Ed è per questo e per altri motivi che il festival dichiara questa edizione come l’ultima di un percorso. Un punto di svolta e al contempo un momento per riflettere su quanto si è raccolto, cogliere i frutti di un cammino che alla base pone la cultura all’ascolto di musiche lontane dai grandi riflettori.
Ne abbiamo parlato con Alessandro Gambo, ideatore e curatore del festival, che ci ha raccontato come nasce un programma così articolato, tra inseguimenti discografici, passioni coltivate da anni, scelte audaci e una visione che mette al centro l’accessibilità e la coerenza artistica più che i numeri. Un dialogo che attraversa decenni di ascolti, aneddoti da backstage e un’idea di comunità fondata sull’amore per la musica.
L’edizione numero otto di Jazz is Dead ha un titolo evocativo, proprio come quelli delle edizioni che l’hanno preceduta. Perché “Infinito”?
Lavorare e creare progetti per questa edizione è stata una cosa infinita. Poi si gioca facile col fatto che, essendo la numero 8, ribaltando di 90 gradi il numero diventa il simbolo dell’infinito. All’inizio pensavo di fare un’edizione senza pause musicali: avere la musica anche al mattino, magari con sleep-in concert, e non fermarci mai. Poi, in realtà, la produzione mi ha guardato malissimo, quindi ho dovuto limitare le mie fantasie. Però è un’edizione infinita perché, intanto, come numero di date siamo cresciuti — di quattro in più rispetto all’anno scorso, se non cinque.
Ad esempio, con il Torino Jazz Festival ne abbiamo fatta una in più rispetto all’anno scorso con John Zorn; quest’anno abbiamo raddoppiato col Planetario e, in totale, ne facciamo tre anziché una sola. Abbiamo aggiunto un giorno in più anche durante i quattro giorni del festival. E abbiamo firmato una collaborazione — la prima — con Jazz Re:Found: il lunedì, che è la giornata dedicata ai bassi potenti, quindi Mad Professor, The Bug, Ghost Dubs e Cortex of Light, è co-firmata con loro.
Quindi, appunto, siamo andati a consolidarci ancora di più nel tessuto — chiamiamolo — Nord-Ovest, e comunque in quello di alcuni festival vicini a noi. E quindi l’edizione è infinita perché, come numero di artisti, siamo sopra il centinaio; come numero di show, siamo ingranditi di molto. Come scrivevo nel comunicato stampa, nell’infinito ci fermeremo.
E sarà questa l’ultima edizione per come conosciamo il festival. Potrebbe continuare a espandersi, potrebbe entrare in un buco nero… questo non lo sappiamo, lo capiremo alla fine dell’edizione. Così non volevo più andare avanti, nel senso che dopo un po’ ci si stufa e c’è bisogno di rinnovamento, e soprattutto stiamo entrando in delle logiche di mercato, di scelte artistiche che potevano andare a compromettere la libertà che abbiamo sempre avuto fino a oggi. E quindi mi sono dato questa edizione come punto di svolta.
Vuoi fermare la corsa nel momento di massima accelerazione
Eh sì, bisogna ogni tanto, secondo me, saper capire quando fermarsi. Fermarsi non vuol dire “ciao, è finita”, significa respirare. Io in questo periodo ho iniziato a fare meditazione, e mi piace come percorso, al contrario dell’idea di continua espansione. Secondo me è rischiosa: si entra in logiche che andrebbero a compromettere l’anima più intima di Jazz is Dead, che è quella della libertà, e di quello che noi abbiamo sempre fatto di pancia più che di testa.
A mio avviso, la conquista più importante di Jazz is Dead è il radicamento nel territorio. Ha creato una continuità — anche grazie agli eventi satellite — e una cultura all’ascolto, magari seducendo una nuova generazione all’ascolto di suoni, suggestioni e modalità di approcciare la musica che, a livello generazionale, non sono più “esposti” come, ad esempio, negli anni ’90
Sì, esatto. Ti rendi conto che io, da promotore, da DJ, sono 25 anni che faccio — concedimi il termine — underground. Sia come DJ, come organizzatore, come selezione musicale e poi dopo con i locali che ho seguito, per cui ho curato la direzione artistica. Il più underground di tutti era il Dr. Sax e poi il Magazzino sul Po.
Lì abbiamo sempre cercato di fare una cultura d’ascolto, di accessibilità, del fatto che appunto bisogna cercare di portare il pubblico, e quindi il pubblico deve rimanere. E a volte, appunto, rendere qualcosa accessibile aiuta, e noi siamo molto contenti di questo, perché si è creata attorno una comunità. Tanta gente viene a Jazz is Dead anche senza sapere quello che ci sarà. Si fidano tanto delle nostre scelte.
Quindi sì, è molto bello. Anzi, molti addirittura mi stanno dicendo che non vanno neppure più a sentirsi gli artisti che non conoscono, perché li vogliono ascoltare in live per la prima volta da noi.
È un po’ lo spirito che Bologna poteva vantare in passato con il vecchio Link: un contenitore dove si andava sapendo di poter — e voler — scoprire cose nuove… Tornando alle collaborazioni, a partire da Milano e Inner Spaces: come sono andate le anteprime?
Milano è andata sold out, Torino con i Calibro 35 eravamo praticamente sold out — cioè non era ufficialmente sold out, ma più di 1400 biglietti strappati. Un numero enorme.
Jan Bang è difficilissimo: artista super di culto, sala piena — non sold out, ma anche lì eravamo all’Hiroshima e abbiamo fatto un ottimo lavoro. C’è stato più caldo, era una produzione originale commissionata da Zenni, direttore artistico del Torino Jazz Festival, che appunto ci teneva tantissimo. È stato lui a chiedermi di aiutarlo, e ho subito accettato. Sono quegli anelli di congiunzione tra i due festival che funzionano. E quindi adesso attendiamo il resto. Sicuramente è un’edizione che, rispetto a quella dell’anno scorso, è puntata sull’infinito: ci sono tante stelle. E anzi, non ci sono solo quelle.
La mia idea quest’anno era quella di un’edizione senza nomi enormi su cui basare la programmazione. Mi piaceva l’idea di avere un’infinita scelta, una galassia di ascolti. Lo scorso anno, la giornata in cui suonò Daniela Pes andò subito sold out. Quest’anno ho immaginato un festival come pura ispirazione internazionale, una realtà che assomigli ai festival che a me piacciono, che costruiscono line-up molto simili alla nostra.
Dove, appunto, sì, ci sono dei nomi altisonanti, ma non il bue da traino. Voglio vedere — e questo sicuramente sarà un punto di analisi quando chiuderemo questa edizione — se Jazz is Dead ha realmente costruito una base solida per cui si può andare a proporre vari nomi tra virgolette anche “sconosciuti”, ma che reggano a livello di presenze. Perché, se appunto torno al discorso iniziale, l’idea di dover costruire un festival con gli headliner e contendermeli tra agenzie e prezzi esorbitanti… no. Vado a zappare, vado al mio orto. Mi dedicherò ad altro. Non è nella logica di Jazz is Dead.
A Torino ci sono già grossi festival, e non c’è partita. Mi è già capitato che non potessi prendere certi headliner perché altri festival della città li avevano già “opzionati” ad altri cachet. E quindi capisci che non voglio entrare in questa logica al rialzo, di rilancio sui cachet. È una follia.
Beh, ma se l’ethos che avete perseguito risulterà sostenibile, non servirà entrare in certe logiche o sbaglio? Penso a Necks o Lorraine James che non hanno molto in comune se non appunto la qualità e l’autorevolezza nei rispettivi ambiti. Così come Egyptian Lover, che non è certo di primo pelo…
Lui avrà 60 anni ormai. E Mad Professor pure, ne ha fatti 70 quest’anno. Chiaro: vai lì e poi vai ai bellissimi Guardia Ferragutti con Frank Rosaly, che ha fatto un album incredibile su International Anthem. Vabbè, l’orchestra è scoppiata adesso, ma in realtà sono vent’anni che suona. Ghost Dubs, che suona lunedì 2 giugno: altro culto. Non voglio sminuire gli artisti che ho portato quest’anno, voglio semplicemente dire che l’headliner da 15.000 euro — che per noi è impossibile da affrontare — non ce l’abbiamo. E meno male.
È un risultato ottenuto in anni di investimento di energie e di curatela, che ha portato poi un pubblico a seguirvi anche da fuori città, anche straniero…
Da fuori abbiamo una grandissima fanbase, anche composta da stranieri. Per assurdo, l’anno scorso avevamo headliner — chiamiamoli così — come Daniela Pes e I Hate My Village, e la gente dall’estero ha risposto molto bene…
Entrando più nello specifico del lavoro che hai fatto per portare questi artisti: c’è qualche retroscena, qualche aneddoto che mi puoi raccontare? Qualcuno che volevi portare da tempo e che finalmente sei riuscito a far arrivare?
Con Lorraine James sì… saranno tre anni che ci sto dietro. C’era un altro grande festival torinese che le stava dietro, che metteva veti, non si poteva fare nulla. Però a un certo punto è uscito un nuovo disco di Whatever the Weather e mi sono detto: “Ok, facciamo lei, così non usiamo il nome Lorraine James”. Poi alla fine Lorraine James ha deciso di fare il progetto autografo, quindi l’abbiamo fatta. E questa è una.
Con i The Necks ci inseguivamo da un sacco, perché è la seconda volta che li porto. La prima volta è stata nel 2019, quando il festival era ancora dentro il cimitero di San Pietro in Vincoli, un luogo piccolissimo, e appunto l’idea era quella di ritornare. E ce l’abbiamo fatta.
Meg l’ascoltavo a 14 anni con i 99 Posse, è stata una parte della mia formazione. L’idea di averla è inoltre legata al fatto che la vedo molto vicina alla visione di Jazz is Dead, come sonorità e per la sua voce, che è incredibile. Poi quest’anno abbiamo tanto bass e dub, e le sue sonorità ci gravitano senz’altro intorno a partire da quelle di Mad Professor con il quale ha collaborato.
Lui lo portai circa dieci anni fa, quando ancora ero giù ai Murazzi. Fu un live epico, e adesso per i suoi settant’anni mi sarebbe piaciuto appunto riportarlo a Torino. E poi c’è The Bug, pensa che ha chiesto lui di tornare a suonare. Tre anni fa si divertì tantissimo con Flowdan. Quest’anno avevamo pensato di fare una Pressure Night, ma non ce la facevo comunque. Già portiamo Ghost Dubs, che è uscito appunto per la sua etichetta: un disco incredibile del 2024 per quanto riguarda la dub più sperimentale. Me l’ha passato lui praticamente. Ci scriviamo regolarmente. È filato tutto abbastanza liscio.
Tu conta che compro dischi della International Anthem: è una delle etichette che seguo maggiormente. Continua a sfornare bombe, ecco perché della label quest’anno abbiamo tre artisti, tra cui Alabaster DePlume e Ruth Goller. Sarà quest’ultima ad aprire il festival venerdì con Schilla. Dell’etichetta mi piace quel filo rosso che lega le produzioni, il background particolare degli artisti, la ricerca. Tutte musiche, produttori e artisti che seguo.
Altre etichette che segui e ami particolarmente?
C’è la Ideologic Organ di Stephen O’Malley. Siamo su tutt’altre sonorità. Ho due album di raga indiani sempre stampati da loro. Per loro esce Lucy Railton (vedi Blue Veil). È una delle etichette su cui vado sul sicuro, assieme alla Impulse! e le sue ristampe. Poi, beh, c’è la Backwoodz: per la quale sono usciti gli ShrapKnel, che sono del giro di Billy Wood, suoneranno sabato 31 maggio. È rap bello scuro, underground, mi piace un sacco.
Altri ascolti che ti hanno colpito ultimamente?
Ho comprato la ristampa di Voodoo di D’Angelo, che è un rapper americano zarrissimo. Copertina inguardabile, con lui a petto nudo e crocifisso. Disco incredibile, a cui non avevo mai dato peso proprio perché la copertina era una di quelle che ti facevano dire “no, anche no”. E in realtà è stata una scoperta della madonna, quindi grande ristampa — assieme a quella che Warp ha fatto uscire dei Red Snapper. Il titolo è Reeled and Skinned, 30 anni, anniversario bomba.
Poi c’è un gruppo fighissimo, si chiamano Organi. Mi manca il nuovo album, Babilonia, ma mi piace più quello prima, che si chiama Parlez-vous français, del 2021. Ho la fortuna di avere un pusher musicale da cui ricevo almeno 30 titoli al giorno… Mi capita di perdermi in questi ascolti e non vado neanche a vedere chi ha fatto cosa. Poi ti accorgi che torna tutto. Questa è la cosa curiosa, perché dici “bello, bello, bello”, metti via, metti via, metti via… e scopri di aver ascoltato 20 dischi della International Anthem.
È come se certi suoni ti venissero a cercare…
Esatto, proprio così.
Per chiudere, c’è qualcosa di cui non abbiamo parlato che vorresti dirmi?
Il discorso sull’accessibilità credo sia importante ribadirlo. Nel senso che, seguendo la linea dell’anno scorso, chi non può permettersi il biglietto lo paga il 30% in meno. Noi non controlliamo nemmeno: se il biglietto al giorno costa 15 euro e non puoi permettertelo, lo facciamo a 10. È una cosa che abbiamo ripreso dal Café OTO di Londra. Il club della vita.
L’articolo Jazz Is Dead 2025: l’infinito e oltre, intervista ad Alessandro Gambo proviene da sentireascoltare.com.